Libri • 7 Aprile 2025
“La gestione e il riuso delle chiese cattoliche in una prospettiva comparata. Un’indagine tra Belgio, Francia e Italia” di Davide Dimodugno
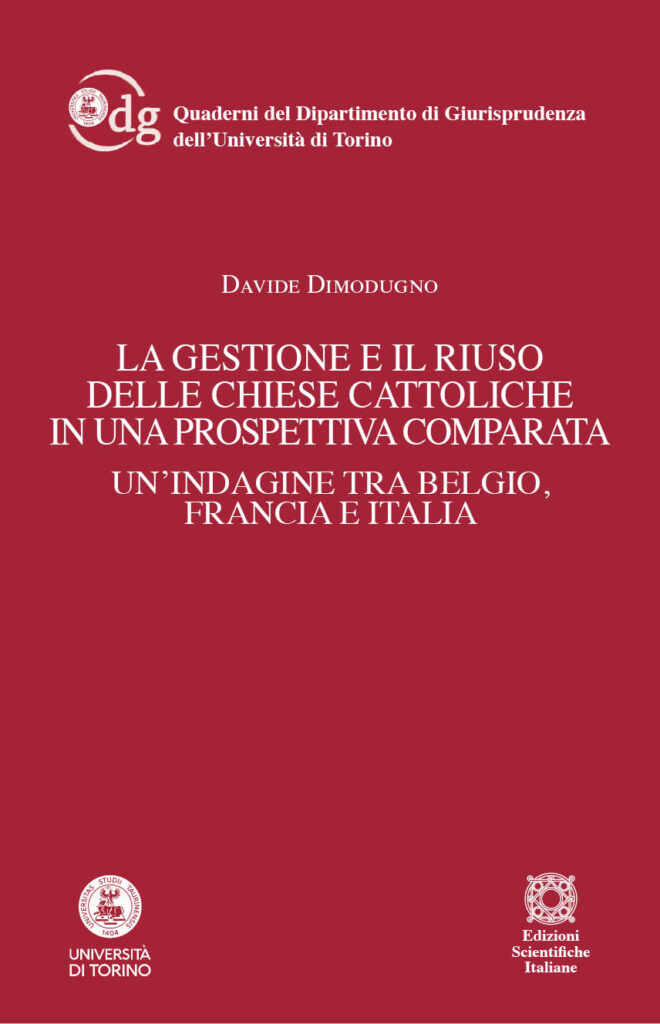
La riflessione sui temi della gestione e del riuso degli edifici di culto, già avviata in una precedente monografia, giunge a compimento in questo volume mediante l’approfondimento delle esperienze di Belgio e Francia. Questi Paesi, seppur di antica tradizione cattolica, sono oggetto da decenni di un processo di secolarizzazione avanzata. La comparazione con l’Italia ha inteso indagare come i diversi sistemi di relazione tra Stato e confessioni religiose e la molteplicità di normative coinvolte incidano rispetto all’emanazione dei decreti di dimissione ex can. 1222 § 2 e all’attuazione di ipotesi di riuso o di uso misto nello spazio o nel tempo. Sono così individuate proposte di soluzione per il contesto italiano che si ispirano alle migliori pratiche internazionali, fondate sul dialogo, sulla collaborazione e sulla partecipazione.
Il testo presenta in tutta la sua complessità il caso belga, in cui vige ancora l’istituto della fabrique d’église, ente pubblico deputato a gestire gli aspetti materiali del culto, con riguardo alle chiese cattoliche costruite prima del 1802 e che risultano tuttora di proprietà dei Comuni. Alla luce della forma di governo federale che caratterizza il Regno del Belgio, sono accuratamente esaminate le normative in materia di gestione degli aspetti materiali del culto e di tutela del patrimonio culturale, vigenti nelle regioni delle Fiandre, della Vallonia e di Bruxelles-Capitale, nonché nella Comunità germanofona. In particolare, nelle Fiandre è stato da anni introdotto il “piano strategico sul futuro delle chiese cattoliche parrocchiali” che ha costretto le comunità civili e religiose a confrontarsi e a riflettere insieme, su un arco temporale di medio e lungo periodo, circa l’uso attuale e futuro delle chiese, nella prospettiva di una loro valorizzazione culturale, di un loro uso misto nello spazio o nel tempo, ovvero di un loro riuso per scopi profani.
Con riguardo al caso francese, in cui la mancata costituzione delle associazioni cultuali da parte della Chiesa cattolica ha determinato l’acquisizione alla proprietà pubblica delle chiese costruite dopo il Concordato napoleonico e prima dell’entrata in vigore della legge di separazione del 1905, la soluzione che è stata individuata a livello giurisprudenziale e che poi è stata recepita dal legislatore è quella dell’accordo tra i Comuni proprietari e l’autorità religiosa affectataire, al fine di regolare e gestire le visite culturali e le altre attività profane ritenute compatibili con il culto dal preposto all’officiatura. La recente indizione degli Stati generali del patrimonio culturale religioso francese e l’apertura di una raccolta fondi a livello nazionale dimostrano che, anche in un contesto di forte secolarizzazione e di rigida separazione, come è quello francese, questi beni riescano a far convergere intorno a sé l’interesse di una comunità più ampia dei soli fedeli.
Tutti questi elementi ci portano a concludere circa la necessità di una modifica sia della normativa statale italiana sia di quella canonica particolare, al fine di agevolare la partecipazione delle comunità con riguardo all’individuazione dei nuovi usi e a favorire soluzioni di uso misto nello spazio o nel tempo, rispetto alla dimissione definitiva. Quest’ultima, laddove non altrimenti evitabile, dovrebbe essere comunque riservata ad usi a carattere sociale o culturale in grado di generare ricadute positive sulla comunità, magari mediante il coinvolgimento di enti del Terzo settore. Le chiese cattoliche, ancorché dimesse, mantengono infatti un valore per l’intera comunità civile, indipendentemente dall’appartenenza religiosa di ciascuno, e, alla luce della base teorica offerta dalla teoria dei beni comuni, dovrebbero essere gestite mediante il ricorso a modelli di governance in grado di contemperare una pluralità di interessi diversi, religiosi e culturali. Questa è la prospettiva tracciata anche dalle convenzioni internazionali in materia di patrimonio culturale alle quali l’Italia ha aderito ma a cui ancora stenta a dare concreta attuazione.

